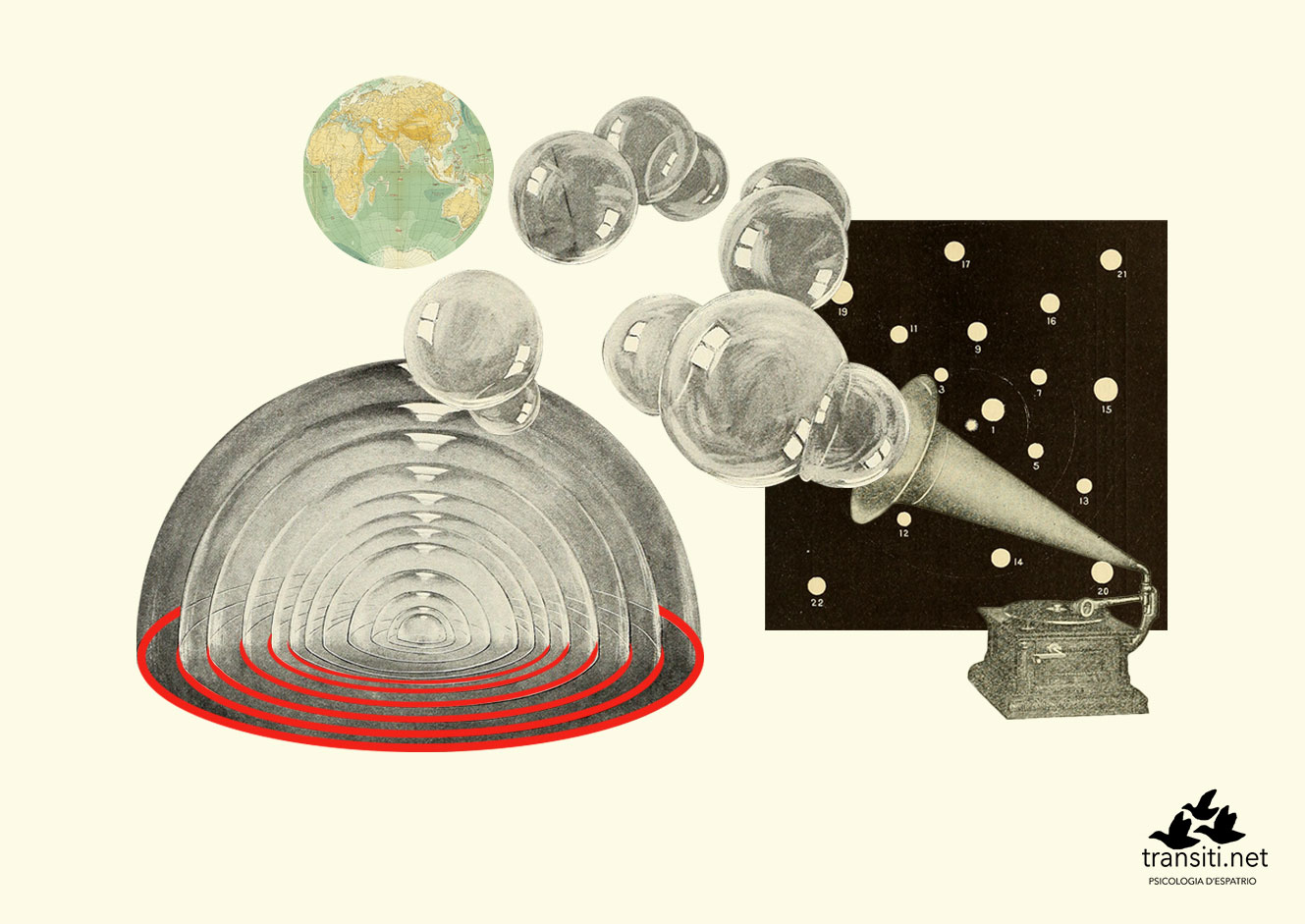Cinzia è seduta sul divano, intenta in una lettura che racconta l’esperienza di una coppia di italiani che vivono alle Falkland: “Che posto stupendo! Chissà per quale motivo sono finiti a vivere laggiù?”. Seduto accanto a lei il marito commenta: “Probabilmente il marito è biologo marino ed è andato a fare qualche ricerca sui pinguini”. Cinzia lo guarda perplessa. Perché il motivo del trasferimento deve coincidere sempre con un’opportunità lavorativa per il marito?
Questa vicenda, realmente accaduta, apre a una serie di riflessioni, apparentemente scontate, applicabili a tante storie diverse e differenti punti di vista che hanno in comune pregiudizi e giudizi che, nella maggioranza dei casi, possono portare a mettere in un angolo le ambizioni professionali femminili in nome della semplificazione dei ruoli in famiglia.
Mentre la rinuncia della donna al proprio posto di lavoro per seguire il marito in un’esperienza all’estero è un modello diffuso e socialmente accettato, conosciuto con il nome di “trailing spouses” o “accompanying expatriate partners”, le coppie che compiono la scelta contraria si ritrovano spesso a giustificarsi, o a doversi ritagliare nuovi spazi nella società.
Il termine “trailing spouses” è stato coniato nel 1981 per definire le mogli che seguivano i mariti espatriati per lavoro e che, tra le mura domestiche nel paese di espatrio, si occupavano della casa e dei figli. Il termine ha assunto negli anni sempre maggiore rilevanza perché ha fatto emergere il particolare e sbilanciato rapporto di forza tra i partner “trainanti” che sponsorizzano e guidano l’espatrio e i partner “trainati”, che si spostano principalmente per garantire vicinanza e continuità della relazione di coppia. A partire dalla fine degli anni ‘90, ulteriori ricerche e riflessioni hanno portato alla luce l’importanza del progetto di espatrio della coppia e dei movimenti all’estero come processi condivisi in cui i ruoli tra partner richiedono supporto, distribuzione adeguata dei compiti e una progettazione della traiettoria d’espatrio inclusiva e dignitosa anche per gli “accompanying expatriate partners”, ossia i partner accompagnanti. Nonostante oggi si adotti questa formula per indicare un qualsiasi membro della coppia senza distinzione di genere, l’espressione “trailing spouses” è ancora molto utilizzata.
Eppure, l’argomento “uomini accompagnanti” è stato più volte sdoganato dal celebre fumettista canadese Guy Delisle, che in alcune graphic novel di viaggio, come Pyongyang, Shenzhen, Cronache Birmane e Cronache di Gerusalemme, racconta con stile leggero e autoironico le sue esperienze di marito a seguito della moglie che lavora per Medici Senza Frontiere.
La sua è una condizione di “accompagnatore” che ricopre il ruolo di padre casalingo anche in contesti dove questa figura è molto meno comune; è vista con curiosità, e a volte anche con sospetto, in ambienti expat esclusivamente femminili dove gli stereotipi di genere che vi regnano rendono la sua posizione particolarmente insolita.
Seguire le ambizioni femminili: una stranezza
Seguire le ambizioni di un partner è spesso considerato normale, quindi, purché sia la donna a farlo per l’uomo, in quanto in molte società la carriera femminile è ancora vista come secondaria rispetto a quella maschile e un cambiamento di prospettiva porta a un disorientamento.
“Pochi anni dopo il matrimonio, quando nostra figlia era ancora piccola, ho lasciato il mio lavoro per seguire mio marito all’estero”, racconta Giada, italiana oggi residente in Svizzera.
“Una cosa del tutto normale, agli occhi di molti, ma non per me. Questa situazione mi pesava, e non mancavano i giorni in cui mi sentivo apatica e poco motivata. È durata un paio di anni, e l’esigenza di intraprendere di nuovo un percorso lavorativo, oltre a contare sulla mia indipendenza economica, è diventata prioritaria. È stata un’offerta di lavoro in un’altra città, sempre in Svizzera, che ci ha portati ad affrontare prima la questione, e poi la scelta di trasferirci.
Premetto che mio marito non ha dovuto rinunciare al suo lavoro, che riesce a svolgere prevalentemente da remoto. Eppure, nonostante i benefici per me fossero evidenti, ho ricevuto una pioggia di critiche non richieste dai parenti o alcuni amici, anche persone dalle quali non mi sarei mai aspettata opposizione.
La suocera prima tra tutti: sosteneva che il mio povero marito fosse costretto ad accontentarmi, che avrei dovuto adattarmi e accettare la mia condizione di casalinga, nonostante i miei desideri fossero altri. Quando sono gli estranei a esprimere pregiudizi possiamo anche liberarcene subito, ma se l’ingerenza è da parte di persone che dovrebbero supportarci trovo sia molto pericoloso, possono risentirne gli equilibri famigliari.
Ci siamo sentiti dire, da amici, che in una famiglia non possono fare carriera entrambi! È stato parecchio frustrante, ma in seguito ho capito che non potremo mai ambire alle pari opportunità se prima non portiamo allo scoperto la rigidità e scarsa flessibilità dei ruoli all’interno della famiglia.
Inutile dire che, a distanza di tempo, non torneremmo indietro, e da quando mi sono inserita nel mondo del lavoro, nonostante le fatiche genitoriali, il nostro equilibrio di coppia è senza dubbio migliorato. Se non siamo riusciti a essere un esempio per coloro che ci hanno giudicato, per lo meno lo saremo per i nostri figli e le nuove generazioni”.
Un muro di pregiudizi che opprime il ruolo maschile
Quando i ruoli si ribaltano, emergono pregiudizi radicati che penalizzano entrambi i sessi; se quando parliamo di stereotipi di genere con connotazione negativa pensiamo a quelli femminili, non sono di sicuro da meno quelli maschili.
“Dopo una decina di anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, sentivo la necessità di investire in un percorso di formazione che avrebbe potuto aprire le porte a un avanzamento di carriera”. È l’esperienza di Elisabetta, all’epoca impiegata in un’azienda di import-export a Milano.
“L’opportunità era negli USA, e dopo averne parlato con il mio datore di lavoro, mi è stato proposto il trasferimento nella sede americana e di non lasciare il mio posto; ero a New York, dove ho conosciuto mio marito, di origine colombiana ma cresciuto negli USA. Alla fine del mio periodo di trasferta, che prevedeva solo un anno negli USA, abbiamo deciso insieme di non lasciarci e lui mi ha seguita nel mio nuovo progetto lavorativo, questa volta in Texas, dove è nata nostra figlia e, poco tempo dopo, anche il secondogenito.
Quando il mio congedo di maternità è terminato – e negli USA è davvero irrisorio – ci siamo trovati di fronte a una scelta: assumere una babysitter, con costi elevatissimi, oppure trovare un’altra soluzione. Mio marito ha deciso di posticipare la ricerca del lavoro per occuparsi dei bambini. All’inizio non è stato semplice per lui: avrebbe preferito lavorare, ma lo ha fatto per la nostra famiglia e per tutelare il mio impiego, che ci garantiva più stabilità economica e anche la flessibilità di tornare in Italia quando necessario.
Mentre abbiamo raggiunto, anche se a fatica, un buon equilibrio come coppia e famiglia, attorno a noi il giudizio degli altri è stato feroce.
I miei genitori lo definivano “mantenuto”, e mio cognato addirittura “nullafacente”. La sua famiglia mi ha etichettata come una moglie sfruttatrice, che non si preoccupa del futuro del marito e che ostacola le sue opportunità di carriera. Opinioni non richieste, che feriscono, nonostante si tratti di una fase temporanea – due figli piccoli da crescere – e per noi la scelta più logica.
Posso facilmente immaginare che se fosse successo il contrario – ovvero io a restare a casa per due anni con i bambini – nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. I pregiudizi di genere non danneggiano solo le donne, ma anche gli uomini: impongono ruoli rigidi e creano aspettative soffocanti. L’uguaglianza rimarrà solo una bella idea scritta su carta, se non penseremo alle norme sociali che regolano i rapporti di genere”.