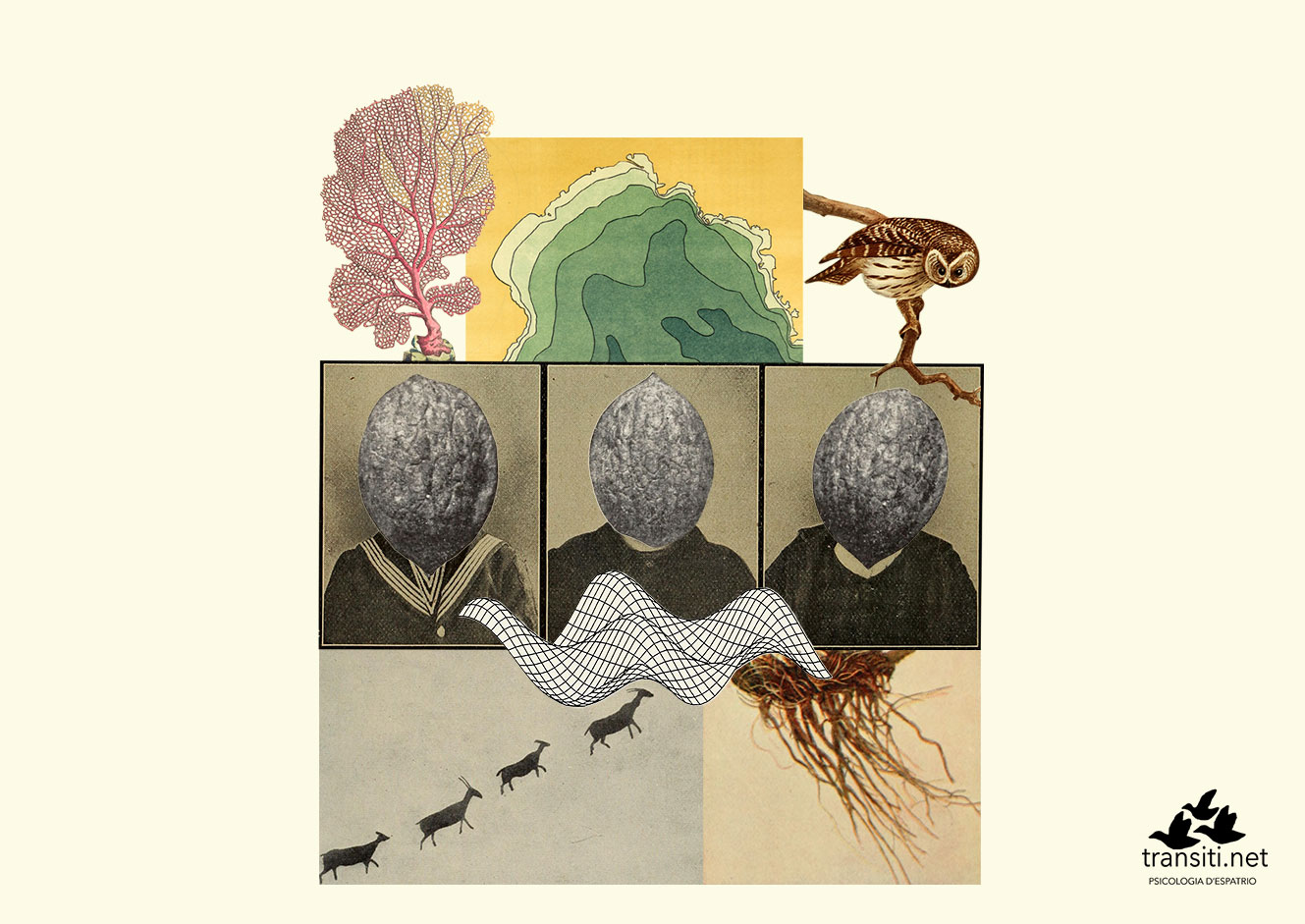Giulia vive in Norvegia da alcuni anni, dove ha incontrato un uomo norvegese di cui si è innamorata. Insieme hanno avuto Claudio, che ora ha un anno e mezzo. Riflette così: “Prima di diventare mamma non mi ero mai posta certi interrogativi. Ora mi chiedo se mio figlio sarà parte della comunità norvegese, quando ancora io fatico ad esserlo. E mi sto accorgendo, da quando c’è Claudio, di attaccarmi sempre di più a certi aspetti di “italianità” che prima non consideravo così importanti”.
Andrea vive in Romania con la sua compagna romena da 10 anni. Hanno due figli, Daniel (di 4 anni) e Teo (6 mesi). Ci racconta: “Da quando ci sono i bambini la questione della lingua è diventata saliente: io non parlo romeno e fino al loro arrivo questo non è stato un grande problema (con la mia compagna si parlava inglese, così come sul lavoro). Adesso, però, una domanda che mi faccio spesso è: quanto i miei figli si sentiranno italiani, vivendo qui e parlando italiano solo con me? Sì, perché per me è importante, anzi fondamentale, che parlino anche l’italiano.”
Paolo abita in Spagna, dove sta crescendo, insieme a sua moglie italiana, un bambino che ora ha 3 anni. “Noto che da quando sono diventato papà è cambiato anche il rapporto con i miei genitori, che abitano in Italia. Per loro adesso non sono soltanto figlio, ai loro occhi sono diventato anche un padre. E questo ha portato grandi novità, per me tutte positive.”
Queste voci, raccolte in uno dei gruppi di sostegno alla genitorialità di Transiti, fanno risuonare note diverse sullo spartito della genitorialità, che hanno però in comune una tonalità ben precisa: il cambiamento.
Le “3 C”: cambiamento, crisi, creatività
Diventare genitori implica una radicale trasformazione a più livelli: di identità individuale, di relazioni di coppia, di relazioni con le famiglie d’origine e con il contesto sociale entro cui si è inseriti.
I ritmi di vita cambiano non solo quando nasce un bambino, ma anche quando inizia un nuovo ciclo scolastico o acquisisce una nuova tappa dello sviluppo psicofisico (per esempio, quando impara a camminare, a parlare).
Sfide, nuovi problemi, trasformazioni continue: tutto ciò ci pone di fronte a due “c:” crisi e creatività. Immaginiamo questi concetti come due facce della stessa medaglia, quale è l’esperienza della genitorialità.
- Crisi, perché di fronte a nuovi compiti di sviluppo si può vacillare, ci si chiede come fare e se si sarà in grado. Possono aumentare i momenti di conflittualità con il partner e/o con le famiglie di origine. Le situazioni più complesse da gestire per i genitori sembrano essere quelle legate al cambiamento e alla spinta evolutiva che conduce i piccoli verso l’autonomia e l’autodeterminazione. La gestione delle crisi di rabbia, del sonno o del distacco, ad esempio, possono sembrare compiti molto diversi, ma rivelano un denominatore comune. L’acquisizione di queste tappe è legata ad un intreccio di fattori quali la maturazione delle strutture cerebrali – che sottendono, ad esempio, i ritmi del sonno maturo o la regolazione emotiva –, la relazione con le figure di riferimento e i modelli di comportamento che gli adulti offrono ai più piccoli.
- Creatività, perché maternità e paternità comportano enormi potenzialità di crescita per sé come individui. Si aprono nuove consapevolezze e una maggiore possibilità di conoscenza di sé, si allenano capacità e si scoprono risorse che prima nemmeno si sospettava di avere. Pensiamo alla capacità di fare più cose contemporaneamente, oppure alla scoperta di emozioni e sentimenti profondamente disinteressati, fino ad arrivare alla sperimentazione della totale dipendenza di un altro essere umano. Ma, anche, la gestione delle sfide di un adolescente o il desiderio di veder realizzato l’altro come persona, nella sua interezza e lungo la sua strada.
Premesse implicite sulla genitorialità: le “culture” della nascita
Ognuno di noi porta con sé una serie di idee, concetti, pregiudizi e miti su come si allevano bambini e bambine, chi li deve accudire, ecc., che hanno le loro radici in storie familiari antiche e profonde: si chiama cultura della nascita. Nessuno ne è sprovvisto, ma finchè non si diventa genitori, non è particolarmente saliente. Nella maggior parte dei casi rimane come sotto pelle, poco accessibile alla consapevolezza. Quando si diventa mamme e papà, soprattutto con l’arrivo del primo figlio o della prima figlia, ecco che la cultura della nascita balza fuori, più o meno consapevolmente, con tutti i suoi corollari.
E così accade che i partner inizino a discutere, ciascuno partendo dalle proprie premesse implicite, su molteplici questioni: dove partorire, da chi farsi aiutare, quali strutture scegliere, dove farlo/a dormire, che approcci educativi utilizzare, ecc. Nelle scelte, nelle aspettative, nelle gioie e nei timori, ognuno dei membri della famiglia porta infatti con sé la cultura che la propria famiglia d’origine ha costruito intorno alla nascita, alla cura e all’educazione dei bambini e delle bambine. Spesso, accade che i neogenitori siano acritici rispetto ad essa, dando per scontati e definendo come “naturali” punti di vista che sono invece culturali, propri dell’epistemologia della famiglia d’origine.
Essere critici rispetto all’educazione ricevuta non vuole dire buttare via il bambino con l’acqua sporca. Significa essere profondamente consapevoli che il modo in cui siamo stati cresciuti dai nostri genitori è solo uno tra i tanti possibili (e così quello che hanno utilizzato i nostri suoceri con il/la nostro/a partner). Tanto più avremo affrontato e superato i nodi irrisolti con la famiglia da cui proveniamo, tanto più saremo aperti alla cultura della nascita del nostro partner e ne potremo accogliere gli aspetti più utili che, mischiati a quelli della nostra , concorreranno a costruire una “terza” cultura della nascita, quella della nostra famiglia nucleare. I nodi si affrontano e si risolvono quando siamo in grado di provare gratitudine per i doni ricevuti ed accettare le mancanze, andando oltre. Questo è un ottimo punto di partenza per instaurare con i nostri figli e figlie una relazione improntata all’amore ed al rispetto, oltre che al contenimento ed al supporto.
Negoziare tra le diverse culture della nascita
Quando si vive in un paese altro rispetto a quello di origine, poi, la faccenda si complica ulteriormente, perché a questo affresco si aggiungono anche i colori delle culture della nascita e delle pedagogie implicite proprie di quel paese in cui si è espatriati. Molto spesso le pedagogie implicite del paese di arrivo sono diverse da quelle che i genitori italiani in una traiettoria di mobilità hanno conosciuto nel contesto di origine.
Facciamo un esempio (che, ben consapevoli delle eccezioni, serve unicamente per dare un’idea): la scuola italiana premia particolarmente la creatività degli allievi: riceve un voto alto, o un elogio, lo studente che esegue un compito in modo diverso dagli altri (seppure entro certi schemi prestabiliti), che, insomma, trova una soluzione innovativa ad un problema, che si distacca dal gruppo.
Nella scuola cinese accade l’opposto: solitamente è premiata la capacità di replicare un modello fornito, di abdicare a parti della propria individualità a favore della collettività. In generale, la creatività è scoraggiata, a favore dell’importanza di adeguarsi ad un modello prestabilito.Si pensi quindi ad una famiglia italiana, i cui figli sono inseriti nel sistema scolastico cinese: sarà necessario un grande lavoro di negoziazione sui propri impliciti, per favorire una positiva esperienza scolastica dei minori.Ovviamente, vale anche l’esempio contrario.
In caso di coppia mista, poi, intervengono gli aspetti culturali impliciti ed espliciti di entrambi i partner, che possono essere anche profondamente distanti.
In Finlandia, molti genitori scelgono di far fare il riposino ai propri figli e alle proprie figlie all’aria aperta, sin da quando sono molto piccoli. In Italia è diffusa l’idea che prendere freddo faccia ammalare, pertanto bambini e bambine nei mesi invernali vengono solitamente portati fuori molto coperti, possibilmente nelle ore più calde della giornata. Ecco un esempio di come un tema quotidiano, in una ipotetica coppia italo-finlandese, potrebbe essere motivo di scontro, ma anche di grande arricchimento, se ben gestito.
Si deve tenere in conto che questa grande complessità si inserisce anche in un contesto storico nuovo e del tutto differente da quello in cui hanno vissuto le generazioni passate, che non può non avere conseguenze sulle modalità di vivere l’esperienza della genitorialità.Dobbiamo, infatti, prendere atto che il ruolo delle figure genitoriali è decisamente cambiato negli ultimi 50 anni. Come ben mette in luce il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti, “prima del ’68 vivevamo l’età della disciplina, il messaggio della famiglia coincideva con il messaggio della società: se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi lavora e sacrificati.” Se un tempo i ruoli genitoriali erano fissi e incasellati abbastanza rigidamente in una separazione tra l’autorità (padre) e l’accudimento (madre), oggi sono molto più vicini, flessibili e intercambiabili. Rispetto ai modelli passati, in cui vi era una sostanziale sovrapposizione tra i messaggi del contesto sociale e quelli familiari (= lavora sodo e avrai successo), oggi i modelli educativi a cui i genitori sono esposti sono molteplici e a volte in contrapposizione tra loro.
Alcuni genitori lamentano uno stato di confusione dovuto a un overload di informazioni, frequentemente in contraddizione tra loro, che spesso disorienta, mettendo in difficoltà chi deve prendere una decisione. Infatti quando si ha un dubbio, oppure una perplessità, sull’educazione dei figli, la facilità di accesso all’informazione è notevole e le fonti da cui attingere sono molteplici, a partire dai social, dal web, per arrivare ai libri e ai professionisti, con il risultato che una parte dei genitori si sente disorientata.
In caso di traiettorie di espatrio, per i motivi sopra esplicitati, queste dinamiche si potenziano.
Quello che, però, rimane comune a tutte le esperienze di genitorialità, è che, citando Silvana Quadrino, di fatto “si diventa genitori diventandolo” (da Diventare grandi, insieme. Fare i genitori con l’aiuto del bambino. UPPA edizioni, Roma 2019. pp. 285): come genitori si cresce, cioè si cresce insieme ai propri figli e alle proprie figlie.
Diventa prezioso, allora, non smettere di interrogarsi sul significato delle proprie scelte educative, come individui e/o come coppia.
Essere genitori presenti
Oggi le neuroscienze ci dicono che “per dare alle nostre figlie e ai nostri figli le migliori possibilità di sviluppo sano e ottimale, tutto ciò che occorre fare è aiutarli a sentirsi protetti, compresi, confortati e sicuri”, sostiene lo psichiatra Daniel G. Siegel, autore di “La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale”. Essere presenti, per loro e accanto a loro, è ciò che più conta; i bambini hanno bisogno di sapere che gli adulti fanno il tifo per loro e che i genitori sono un “porto sicuro” sia dal punto di vista emotivo che relazionale.
E questo si può fare vivendo nel proprio luogo d’origine, così come a migliaia di km di distanza.