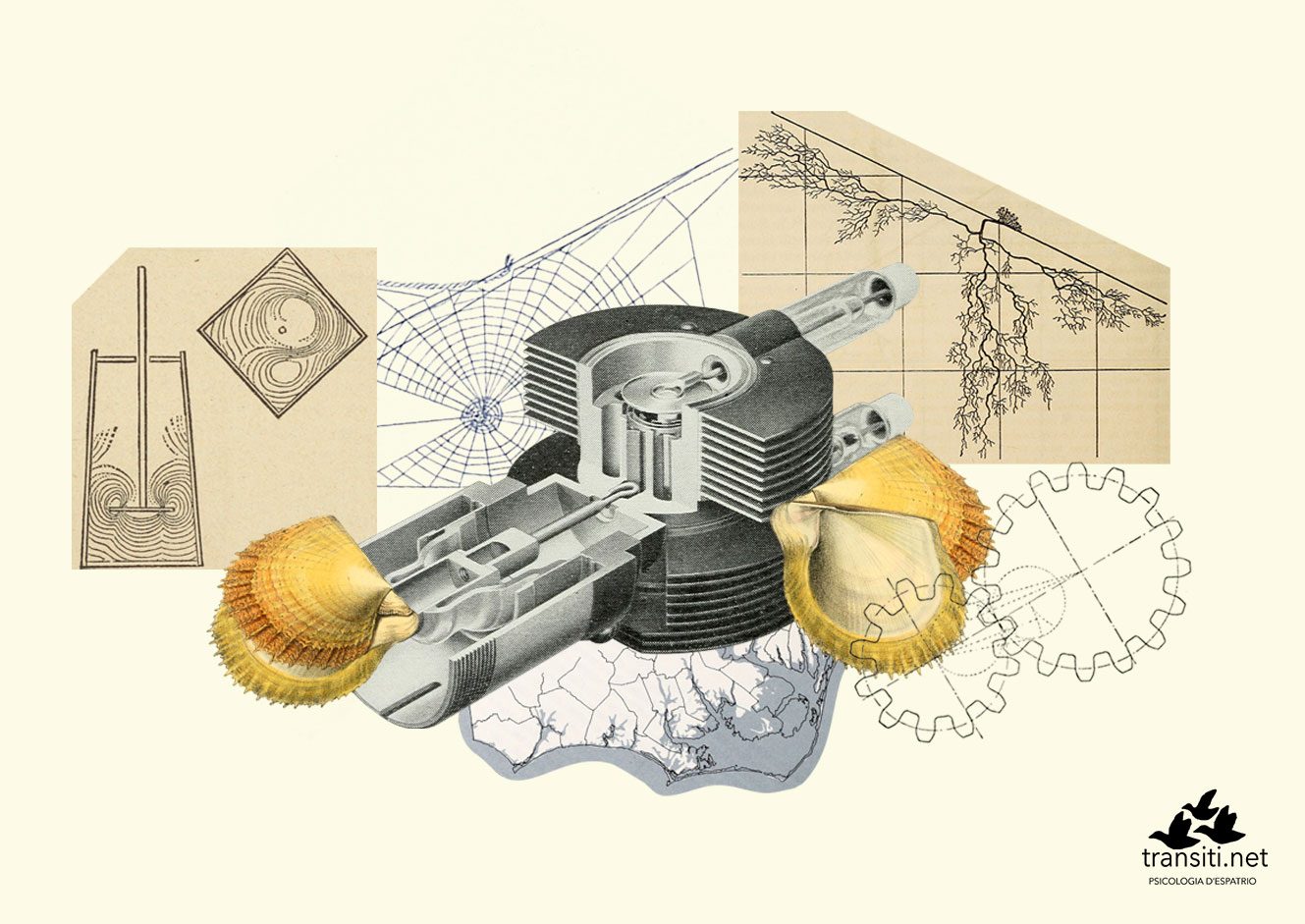“Per me incarnare un ruolo apicale in un’organizzazione che si propone di coordinare una collettività da oltre 6 milioni di persone attraverso una rete di 2000 volontari è un ruolo da allenatore, non da attaccante”.
Maria Chiara Prodi è stata eletta Segretaria Generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) a giugno 2024. Ricopre, pertanto, un fondamentale ruolo di rappresentanza per coloro che fanno parte di quei 6 milioni e più di italiane e italiani che vivono al di fuori dei confini nazionali. Una comunità in cui anche lei rientra, e che fin da giovane ha potuto osservare da una prospettiva che lei considera privilegiata proprio perché “collettiva”.
Oltre al ruolo volontario di Segretaria Generale del CGIE Prodi di professione dirige, a Parigi, la Maison de l’Italie, una residenza dai connotati particolari: la Maison, situata in un parco nel cuore della Ville Lumière, fa parte della Cité Internationale Universitaire di Parigi (CIUP), un luogo d’incontro e scambio tra culture. Nelle sue 43 maisons (case), dà ogni anno ospitalità a 12000 persone con diverse provenienze nazionali che vi si trovano per ragioni di studio e di ricerca.
E’ qui, alla Maison, dove siamo volati per presentare il nostro libro “Traiettorie. Guida psicologica all’espatrio”, che è avvenuto l’incontro tra Transiti e Maria Chiara Prodi.
Una traiettoria di mobilità tra il personale, il collettivo e il politico
L’Erasmus e i progetti universitari rappresentano, per molte persone, un trampolino di lancio per l’espatrio, la miccia che permette l’accendersi dei percorsi di mobilità internazionale. E’ stato così anche per il percorso di Prodi, sebbene con delle specificità tutte sue: “La mia traiettoria parte da Bologna: da lì, un Erasmus a Parigi tra 2000 e 2001, dove sono tornata per fare ricerca per la mia tesi e, in seguito, per uno stage all’UNESCO. Poi, nuovamente, per uno stage a Radio France nell’ambito del progetto Leonardo. Mi è stato proposto un contratto di lavoro e da lì in avanti sono rimasta, cambiando più volte posizione lavorativa“.
“Ora che dirigo una residenza italiana all’estero, mi rendo conto che già dai tempi dell’Erasmus per me non sarebbe stato pensabile vivere da sola in una stanzetta. Nel vivere l’esperienza migratoria, già ricercavo attivamente la dimensione della comunità. Convivevo con coinquilini e coinquiline italiane, ci chiamavano ‘la seconda Ambasciata d’Italia a Parigi”, racconta Prodi. “Con questo sguardo comunitario, collettivo, il mio mi è sembrato fin da subito un osservatorio privilegiato sulla mobilità”.
Quella della Segretaria Prodi è una storia di espatrio con doppio indirizzo: “Per me ci sono stati più passaggi per Parigi prima che il transito si ‘arenasse’ nella Ville Lumière. Penso che il mio processo sia stato atipico proprio perché segnato unicamente da due città universitarie, Bologna e Parigi, mentre le traiettorie più comuni, oggi, prevedono tappe di emigrazione in luoghi differenti prima di arrivare a un approdo ‘definitivo’, che talvolta non arriva mai. Non saprei dire se la mia situazione di approdo qui sia permanente. Constato, semplicemente, che sono a Parigi da vent’anni”.
L’esperienza fondativa di ExBO: “risorse sparse ma non perse”
L’apertura alla collettività caratterizza, da sempre, l’esperienza di migrazione di Prodi; essa ha dato l’imprinting – e ampio respiro – alla sua visione della mobilità, della politica e del mondo.
Questa cifra inizia a prendere forma in ambito familiare: lei e i suoi due fratelli, anch’essi emigrati, hanno storie di espatrio e tragitti internazionali tra loro molto differenti. Ad accomunarli, il fatto che non fossero gli unici, all’interno della cerchia bolognese, a far parte di questo flusso migratorio in uscita dall’Italia: contemporaneamente a loro, anche amiche e amici partivano, rientravano, si spostavano.
In una visione di migrazione circolare e non rigidamente divisa in fasi prestabilite, il momento dei rientri in Italia, anche temporanei, è pienamente parte del fenomeno dell’espatrio. Maria Chiara Prodi e i suoi fratelli hanno sempre dedicato molta cura a questi frangenti temporali: quando rientravano a casa per le vacanze di Natale, organizzavano delle feste in cui si riunivano amiche e amici partiti, “partenti”, rientrati o che stavano riflettendo sulla possibilità di emigrare. Dopo qualche anno, hanno iniziato a interrogarsi collettivamente sul fenomeno migratorio che a Bologna interessava molti loro coetanei.
Nel 2008 hanno organizzato un incontro, dal titolo ExBO, nel quale hanno utilizzato la tecnica partecipativa dell’open space technology, che consiste nel mettere attorno a un tavolo virtuale – e ideale – un gruppo di persone accomunate da una domanda. “Le nostre domande, in quanto giovani di Bologna in traiettorie di mobilità, erano: ‘se dovessi tornare a Bologna, che cosa vorrei trovare? Su che cosa vorrei lavorare?’.”, racconta Maria Chiara Prodi.
“In una sola giornata avevamo fatto una mappatura articolata dei desideri, delle opportunità, delle paure, di ‘ciò che si perde’ quando si va via dal proprio Paese. Il risultato è stato, al termine dell’evento, un instant book, una raccolta di diversi temi fondamentali. Emergevano alcuni aspetti rilevanti: che una persona avesse o non avesse fatto esperienza dell’espatrio, o che la stesse per fare, c’erano delle domande rispetto al ‘luogo’ che erano le stesse per tutti, e sostanzialmente legate alla possibilità di avere un luogo internazionale inteso come luogo di opportunità”.
Tra le maggiori preoccupazioni del gruppo spiccava quella che secondo Prodi rappresenta uno degli aspetti più occultati dalla retorica sull’espatrio: come si mantiene il legame “con chi resta”? Quando si intraprende un percorso di mobilità internazionale, come ci si pone in relazione con i genitori che invecchiano e iniziano ad avere bisogno? Come ci si pone rispetto al “dovere morale” di allevare i propri figli e le proprie figlie all’estero trasmettendo la propria cultura e la propria lingua?
“Mi è sembrato subito chiaro che separare ‘chi parte’ da ‘chi resta’ fosse un filtro mediatico, un etichettamento facile del fenomeno che non chiariva il punto reale, cioè che a tutti sta a cuore il fatto di sentire di poter avere delle opportunità, e che la questione della traiettoria di espatrio è complessa proprio per questo”.
“Da queste condivisioni è nata la volontà di rimanere in rete, di sentirci vicini in questa esperienza caratterizzata da molte incognite, non solo personali ma anche sociali e collettive, e di instaurare una relazione con la nostra città che ci ha portato a ripetere l’appuntamento per più anni successivi. Definendoci ‘risorse sparse ma non perse’, nonostante le distanze e le traiettorie di mobilità, volevamo essere dei nodi informativi per Bologna, ‘esserci’ anche se andavamo via. Al tempo non c’era la sensibilità all’idea di un accompagnamento individuale psicologico all’espatrio, però per noi era evidente il bisogno psicologico, affettivo, emotivo, di sentirci comunità nell’esperienza di mobilità, così come la consapevolezza che le risposte a molti quesiti che la vita all’estero ci metteva davanti non potessero che essere collettive. Non solo per inclinazione personale, ma anche per via di questo evento fondativo, questa è da sempre la mia cifra”.
Uno sguardo alle infrastrutture: gli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero
Forte di questi trascorsi, Maria Chiara Prodi ha portato le sue esperienze di vita associativa e collettiva italiana in altre e più ampie realtà: è stata consultrice degli Emiliano-romagnoli nel mondo, antenna a Parigi di Libera, fino ad arrivare a più elevati livelli di rappresentanza, all’incarico volontario di Segretaria del CGIE e a quello di Direttrice della Maison de l’Italie che, oggi, come lei stessa afferma, non “ricopre” ma “incarna”.
Maria Chiara Prodi si definisce ossessionata dalle infrastrutture associative e politiche e il loro funzionamento, perché “se non c’è un’architettura, un metodo, un’organizzazione, si è tutti vittime del nostro tempo individualista e materialista. Una cifra importante del nostro contemporaneo è il fatto di avere dei diritti senza sapere di possederli. C’è una grande erosione del nostro benessere che viene dal non avere consapevolezza del fatto che altri, prima di noi, hanno costruito delle infrastrutture che ci sono utili”.
Il CGIE è una di queste infrastrutture. Si tratta di un organismo di rappresentanza di secondo livello, il cui presidente è il Ministro degli Affari Esteri, e si compone di 20 membri di nomina governativa e 43 consiglieri di provenienza territoriale. Questi ultimi sono eletti, per ciascun Paese, da un’assemblea composta maggioritariamente dai componenti dei Comites, a loro volta eletti da tutti gli aventi diritto al voto – gli AIRE maggiorenni. Ciascuna Assemblea-Paese è inoltre completata da una serie di rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane, in modo che la platea elettorale tenga conto delle complessità e dell’eterogeneità delle comunità stesse.
Spiega Prodi: “La legge istitutiva dice che il CGIE rappresenta le comunità italiane presso tutti gli organismi che mettono in essere delle politiche per gli italiani all’estero. Rispetto al periodo storico in cui questo organismo di rappresentanza è nato, ci sarebbe da ragionare su che cosa significhi ‘comunità all’estero’, chi ne fa parte, se esistono ancora delle comunità o se oggi italiane e italiani in traiettorie di espatrio sono ‘solo’ delle monadi”.
Secondo Maria Chiara Prodi, un aspetto critico riguarda il fatto che, a fronte di una presenza italiana all’estero che è aumentata del 90% negli ultimi vent’anni, il corpo diplomatico consolare è stato fortemente ridotto a livello numerico. “E’ ovvio, quindi, che ci siano delle linee di tensione. Per le nostre reti di rappresentanza di base e per il corpo diplomatico consolare è stato difficile riuscire ad assimilare le importanti ondate migratorie degli italiani verso l’estero, i cui numeri hanno superato quelli dei flussi in ingresso nel nostro Paese. Chiaramente, rappresentare centinaia di migliaia di italiani all’estero è diverso dal rappresentarne oltre 6 milioni, corrispondente al numero attuale di presenze italiane registrate AIRE nel mondo. A questa enorme crisi di crescita secondo me si è affiancato, da parte di chi abitava gli organismi di rappresentanza all’estero, un grande senso di colpa e di impotenza per non essere in grado di recuperare queste onde migratorie”.
Secondo Prodi, inoltre, c’è un fraintendimento che riguarda una – supposta – mancata partecipazione politica delle persone italiane in traiettorie di mobilità.
Per spiegarlo, ricorre a una metafora: “A livello politico, apriamo il rubinetto della partecipazione e vediamo che l’acqua non scorre. Allora pensiamo erroneamente che manchi il desiderio di partecipazione, senza renderci conto che è un po’ come la rete idrica in Italia, in cui l’acqua c’è, ma le tubature la disperdono. Forse è il tempo di domandarci se le tubature sono ancora appropriate: di fronte a strutture associative, partiti politici, strumenti della partecipazione che richiedono una presenza fisica, un diritto di cittadinanza sancito dai documenti, basate su una forma di organizzazione gerarchica che privilegia le persone che hanno molto tempo o molti soldi a disposizione, gli esclusi sono le persone in mobilità, i giovani, le donne. Pertanto si crea uno scollamento tra la facilità materiale dell’esperienza di spostamento e quella della partecipazione attiva”.
“Siamo diventati cittadini del mondo nel senso della mobilità, ma non nel senso della cittadinanza. A fronte di un grande slancio di esperienze migratorie, su tutto quello che è invece infrastruttura politica della partecipazione siamo rimasti novecenteschi, fermi su una forte burocratizzazione del voto e della partecipazione stessa. Sostanzialmente, l’universo delle possibilità trasformative rispetto a ciò che non ci piace cozza con l’hardware della nostra vita, cioè con l’organizzazione del lavoro, delle strutture di partecipazione politica. Il tema è aperto, e credo non possa prescindere dal 10% della popolazione italiana, quella porzione di Italia che sta al di fuori dell’Italia e che, ‘lontana dagli occhi, lontana dal cuore’, non viene vista”.
Accanto a queste problematiche, nel suo ruolo di “allenatrice” Prodi vede anche il potenziale che si può esplorare e “ciò che si può far funzionare, gli aspetti costruttivi che possiamo immettere, visto che siamo, appunto, il 10% della popolazione nazionale totale. Ciò che mi ha spinto a candidarmi a Segretaria Generale del CGIE è che in questi 20 anni abbiamo avuto più opportunità di esercitare il diritto di far sentire la nostra voce di italiani all’estero in Italia”.
Incarnare un ruolo di rappresentanza per le comunità italiane all’estero
L’emigrazione è qualcosa di estremamente complesso; potenzialmente, 6 milioni e oltre di persone iscritte all’AIRE hanno 6 milioni di storie e di traiettorie, pertanto le infrastrutture sono necessarie: chi ha il compito di rappresentarle ricopre il ruolo di allenatore che suggerisce uno schema a un’enorme squadra in cui giocano le persone italiane che vivono al di fuori dei confini nazionali, i 2000 volontari delle rappresentanze di base e delle Consulte regionali per l’emigrazione, squadra che può contare sui 12 parlamentari della Circoscrizione Estero.
“Incarnare un ruolo vuol dire anche accettare di farlo con una modalità che ti corrisponde a livello di personalità, impiego del tempo, organizzazione familiare; con il fatto di essere donna, perché, se lo sei, occupare spazio è più difficile; e con il fatto di voler fare questo lavoro non considerandolo unicamente sul piano di carriera, come un’attività personale”.
“Mi trovo spesso in contrasto con chi si proietta su questi ruoli in maniera predatoria. L’idea del potere, non come verbo ma come sostantivo – non il ‘potere fare cose’ ma l’idea dell’ ‘avere potere’ – è talmente incistata nella testa delle persone al punto che le infrastrutture politiche di partecipazione non funzionano come dovrebbero. Vivere la politica in questo modo eminentemente individuale è, per me, moralmente e psicologicamente sbagliato. Non lo è, invece, pensare a se stesso come a un protagonista, se si occupa una posizione per avviare processi”, afferma declinando in maniera personale le parole di Papa Francesco.
Emigrazione, salute mentale e psicologia collettiva
“Nel nostro tempo individualista e materialista le prime vittime sono le cose che non si vedono, perché la pressione sul lavorare, consumare e sulla felicità individuale – una chimera se non c’è una felicità collettiva – schiacciano tutto il resto e impongono modelli deleteri. La politica, e l’attenzione per la salute psichica, sono le grandi assenti nell’idea di benessere delle persone.”
Dal suo angolo di visuale, Prodi sostiene che “la cifra della migrazione odierna è questa: chi parte lo fa da solo, per motivazioni personali e professionali; non esiste più una migrazione familiare che, attraverso viaggi individuali e poi ricongiungimenti andava a costruire all’estero delle vere e proprie enclave di italiani, delle reti diffuse nei territori”.
Per questo, secondo lei esiste una naturale continuità tra realtà come Transiti e organizzazioni di rappresentanza di base: il disagio individuale nasce dalle difficoltà di un percorso solitario – quello migratorio – che ha delle grosse incognite, rilevate da organismi come il CGIE, che non ha delle risposte collettive. Per chi incarna un ruolo come quello di Segretaria Generale, quindi, il compito è quello di ricordare che “non tutte le soluzioni ai problemi psicologici sono individuali o familiari. C’è un contesto di violenza sociale e politica rispetto alla realtà che viviamo, e dall’altra parte un’impotenza indotta, perché rispetto a un ideale di felicità comunitaria gli strumenti per raggiungerla sono sempre più scarsi. La sfida è un po’ questa: riuscire a rendere coscienti le persone del disagio e della necessità di risposte collettive. Per questo, l’apparire sulla scena di una psicologia che si prende cura dell’espatrio in senso comunitario è un avvento positivo. Per me è un tassello importante che si aggiunge alle battaglie politiche”.
Sul senso della comunità, ovvero sulla felicità umana
Si può avere una prospettiva comunitaria e collettiva sull’emigrazione che tiene insieme chi resta e chi parte? Quali sono le connessioni fra i movimenti che, dall’Italia, vanno verso l’esterno e viceversa? E’ possibile riconoscerli come elementi di uno stesso sistema che si parlano e non come compartimenti stagni? Perché abbiamo bisogno di etichette rigide – migranti, expat, espatriati – per riferirci alla migrazione?
“Nella scelta lessicale c’è sempre un pregiudizio che, per certi versi, è naturale. Le parole non sono mai neutre e non si allargano mai a comprendere quella complessità che, anche desiderando riconoscerla a un determinato fenomeno, lo caratterizza”.
Fin dai tempi di ExBO, Prodi si è battuta contro l’espressione “cervelli in fuga”, sostenendo che non è un cervello ad espatriare, ma una persona con la sua storia e le sue relazioni. Pertanto, quando una comunità “perde” una persona per via di un trasferimento, non perde solo un o una professionista, ma qualcuno che nel tessuto sociale aveva un ruolo: il capo scout, la persona che organizzava il cineforum, quella che faceva volontariato alla mensa popolare etc. “Non si perde il profilo Linkedin ma la biografia sociale di una persona. Il livello della città è quello in cui tutte le relazioni sono più evidenti e personalizzate, e la conoscenza e il riconoscimento della persona sono individuali, personali, diretti. E’ un livello che non può essere mantenuto quando si scavalla oltre il confine regionale o nazionale, in cui ci sono altre dinamiche che si mettono in moto”, afferma.
Per Maria Chiara Prodi, “La comunità non è una cosa astratta” e, ci possono essere centinaia di punti di ingresso per questo “sentimento comunità”. Come noi di Transiti, è convinta che la restituzione di una prospettiva individualista impoverisca la vita delle persone, rendendole più infelici: “Penso che ci sia la tendenza, quando ci si trova in una traiettoria di espatrio, a una povertà creativa: la visione è molto ristretta perché non c’è una ‘ginnastica del guardarsi attorno’, che significa fare rete”. Invece, “Le comunità che ti porti dentro sono plurime, così come le identità di ciascuno. Questo significa che puoi attingere a quelle che ti sono più congeniali e necessarie, feconde, e che nel corso della vita potrai accedere a molte più risorse, non solo personali. Tutta questa abbondanza merita riflessione e soprattutto attivazione, partecipazione, coinvolgimento”.